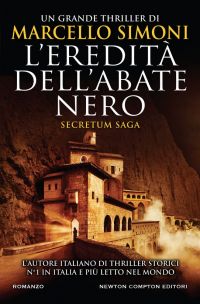
di Marcello Simoni
Trovare il degno protagonista per un romanzo è la croce e la delizia di uno scrittore, soprattutto di gialli e di thriller. Mettere in scena intrecci verosimili e delitti originali non basta infatti ad appassionare chi legge né tantomeno chi scrive. Il segreto di una buona trama, ne sono persuaso, risiede negli eroi che la abitano. Il discorso vale a maggior ragione se chiamiamo in causa i romanzi di ambientazione storica. In questo caso spetterà proprio al protagonista farsi interprete del pensiero, degli entusiasmi e dei disagi del periodo in cui vive, guidando il lettore in un’epoca - e in un’epica - che a poco a poco gli risulterà familiare. È da queste premesse che sono partito per scrivere il mio decimo romanzo, L’eredità dell’abate nero. Dopo numerose scorribande tra il Medioevo e il Barocco, ho ambientato un’avventura nella Firenze del Quattrocento, negli anni cruciali della cripto-signoria di Cosimo de’ Medici. E come protagonista ho scelto un ladro. Una scelta quasi dissacrante, si potrebbe commentare. Un’epoca in bilico tra l’Umanesimo e il Rinascimento parrebbe ben più meritevole di essere vista attraverso gli occhi di un individuo rispettabile. Io però, da scrittore di genere, sono fermamente convinto che la realtà risulti molto più stimolante se scrutata attraverso prospettive inusuali, soprattutto se si parla di contesti storici che, proprio in virtù della loro conturbante bellezza, vengono sovente banalizzati e descritti attraverso dei cliché. E quale migliore occasione, del resto, per omaggiare la leggenda del ladro gentiluomo?
Non alludo a Robin Hood, che in un contesto fiorentino suonerebbe dissonante, ma a Ghino di Tacco, nobile decaduto della casata dei Cacciaconti, vissuto nel Duecento nel Senese e celebrato dalla novellistica italiana come il più significativo esempio di bandito cortese. Dedicandogli una novella nel Decameron, Boccaccio lo definisce uomo fiero pur narrandone le poco lodevoli imprese. Messer Ghino, a capo di una banda di masnadieri, si sarebbe infatti macchiato della colpa d’aver rapito l’abate di Cluny sulla via per Roma. Non privo di rispettosa riverenza, tuttavia, il brigante si sarebbe curato - pur derubandolo - di medicare il religioso e di offrirgli ospitalità nel suo castello. Persino Dante, che nel dodicesimo canto dell’Inferno non si dimostra pietoso nei confronti di «guastatori e predoni», sceglie di citare Ghino di Tacco solo nel Purgatorio, celebrandone la fierezza che, ancor prima di Boccaccio, diviene sinonimo di feroce nobiltà. Non tutti i predoni del Medioevo, tuttavia, suscitarono un simile rispetto, e nella ricerca che mi ha aiutato a definire il profilo di Tigrinus, il ladro protagonista del mio romanzo, ho dovuto muovermi tra realtà e finzione. Com’è prevedibile, mi sono imbattuto in una miriade di espressioni di sdegno e di paura. Gregorio di Tours, nell’Historia Francorum, si esprime per esempio con disprezzo nei confronti di un tal Childerico il Sassone, capo di un gruppo di banditi che nel 589 insidiò senza riguardi una compagnia di suore di Poitiers. Ma se questo accadeva in Francia, chi transitava a sud delle Alpi non se la passava affatto meglio. Secondo le Cronache di Guglielmo di Malmesbury, gli itinerari d’Italia erano così infestati dai briganti che era impensabile percorrerli senza una robusta scorta. Questi ladri, «la cui furia era diretta ugualmente contro il ricco e contro iI povero», non erano dissimili dallo spregevole Tommaso de Courcy di cui parla il monaco piccardo Guiberto de Nogent. Pare infatti che questo Tommaso, un armigero del XII secolo, avesse preso l’abitudine di depredare i pellegrini diretti a Gerusalemme. Il fenomeno è talmente esteso che persino il celebre collezionista di leggende Matteo di Parigi, autore delle Chronica Majora, non esita a raccontare di una gola boscosa vicino ad Alton, nella contea dello Hampshire, dove ai suoi tempi trovava rifugio una combriccola di briganti, ladri e grassatori, tra cui pure alcuni gentiluomini. Il nesso con il Racconto di Gamelyn, l’antica ballata di un brigante di nobili natali rintanato nella foresta di Sherwood, è evidente. Se parliamo di ladri nel Medioevo, però, è forse più intrigante soffermarci sui furta sacra. Non è necessariamente detto, infatti, che intorno all’anno Mille si rubi esclusivamente per appropriarsi di ricchezze mondane. La devozione può essere un ottimo movente, specie se a tesserne le lodi è un agiografo. Mi riferisco alle avventure di quei coraggiosi incoscienti, per lo più chierici e mercanti, che si sarebbero avventurati in luoghi remoti, pericolosi o infestati da pagani per trafugare reliquie di santi dimenticati. Queste imprese, descritte in testi latini detti inventio, non si discostano molto dalla chanson de peste e dalle strutture della fabula definite da Propp. Basti pensare alla translatio di San Nicola o ancor meglio a quella di San Marco, composta intorno all’XI secolo. Secondo questo racconto, i mercanti veneziani Bono e Rustico, sbarcati ad Alessandria, rubarono il corpus dell’Evangelista dal suo antico sepolcro e, per non farsi scoprire dai saraceni, lo tennero nascosto sotto della carne di maiale finché non poterono riprendere il mare. Un’astuzia non da meno trapela dal trafugamento delle spoglie di San Maiano. Ne furono autori due monaci di Colognac, recatisi in un villaggio della Guascogna con l’apposito intento di rubare le veneratissime reliquie del santo e portarle nel loro monastero. Per sfuggire all’ira della popolazione locale, la coppia di religiosi dovette darsela a gambe e far perdere le tracce nella foresta. Più mi dedicavo a queste incursioni storico-letterarie, più ricevevo l’impressione che Ghino di Tacco, pur restando un venale, efferato predone, si distinguesse per un codice di condotta che faceva apparire gli autori dei furia sacra, pur magnificati della Chiesa, dei volgari ladroni. La questione non riguarda la nobiltà del suo sangue, dal momento che un altro feudatario bandito da Firenze e dedicatosi al brigantaggio, messer Rinieri dei Pazzi, fu precipitato senza pietà nell’inferno dantesco. E ciò accadde perché Rinieri rappresenta l’antitesi di Ghino: rapito un vescovo in viaggio per Roma, non si limitò a derubarlo ma l’uccise. Non basta quindi essere ladri, nobili e ribelli per guadagnarsi la simpatia del popolo letterato e non. Si pensi per esempio ai banditi citati nel Novelliere di Sercambi, primi fra tutti Piero da Rabat, «corsale crudelissimo», e il malandrino Suffiello, che rapì la contessa d’Artois. Come accennavo, per risultare graditi ai lettori di storie serve un cuore combattuto, capace di stati d’animo che oscillano tra il bene e il male. Presentate ai lettori simili personaggi e loro li ameranno, anche a costo di trovarli un po’ spacconi. Ragion per cui, ormai sul punto di iniziare a scrivere il mio romanzo, ero giunto alla conclusione che al mio Tigrinus non potesse mancare un pizzico di quella gaglioffaggine per cui fu celebre il poeta maledetto Frarmis Villon. Nato nel 1431 a Montcorbier, orfano di padre e nipote di un rispettato canonico, studiò lettere presso lo Studium di Parigi finché non decise che la vita del fanfarone faceva più al caso suo. Il suo primo colpo risale alla vigilia di Natale del 1456, quando, insieme a una combriccola di due scassinatori, un laureato e un monaco mancato, s’intrufolò in un edificio del collegio di Navarra per uscirne con un bottino di circa cinquecento corone d’oro. Da quel momento, Villon si divise tra la vita del poeta e quella di ladro, del vagabondo e del donnaiolo, uscendo ed entrando regolarmente di prigione. Nel 1460 viene arrestato a Orléans, nel 1461 lo troviamo nel carcere di Meung-sur-Loire e nel 1462 in quello dello Chàtelet. Riuscirà sempre a spuntarla grazie a una fortuna sfacciata e, soprattutto, alle mortificate intercessioni dello zio canonico. Del resto, a questo genere di furfanti siamo disposti a perdonare tutto. Non tanto per la loro capacità di strapparci una risata, quanto per la loro incessante ricerca di libertà che sconfina nella ribellione verso le forme di oppressione sociale. Basti pensare alle parole di Alexandre Marius Jacob, l’anarchico-ladro-trasformista che probabilmente ispirò Leblanc nella creazione di Arsène Lupin. Trascinato a giudizio nel igo3, egli dichiarò: «Una parte del mondo vive nel freddo, nella fame, nel dolore. Io ho voluto vendicarla». Ad anticiparlo, stranamente, è Sant’Agostino, che trascrivendo nel De civitate Dei uno stralcio perduto di Cicerone, accenna a un pirata costretto a render conto delle sue scorribande davanti ad Alessandro Magno. «Per quel che io faccio col mio piccolo naviglio vengo chiamato ladro - disse il predone del mare mentre tu, che agisci allo stesso modo servendoti di una grande flotta, vieni chiamato imperatore». Siamo molto vicini dell’archetipo del bandito sociale teorizzato da Eric Hobsbawm, storico britannico di formazione marxista affascinato dalle ballate e dalle leggende dei fuorilegge popolari. Il ribellismo, l’anarchia, l’individualismo, ma anche il forte carisma sono segni distintivi di questi personaggi. Il codice di un’esigua cerchia di vendicatori morali che abitano nell’ombra. Se quindi di ladri gentiluomini non possiamo espressamente parlare, dovremo accontentarci della più moderna definizione di antieroe: colui che si vede costretto a lottare per definire se stesso e la propria individualità senza aspirare al martirio; a scontrarsi contro un mondo d’ipocrisie portando sulle spalle la croce dell’anarchia. Da Fra’ Diavolo a Fantómas, da Arsène Lupin a Rocambole, la narrativa, le leggende e il cinema ci hanno deliziati per secoli proponendoci questo archetipo dai mille volti, tra guasconate e atti di scellerata libertà. La libertà di essere egoisti, imbroglioni e anche assassini. La libertà di solcare i mari e di correre sui tetti al chiaro di luna, gettandosi ogni cosa alle spalle, amori, dispiaceri, amarezze e sensi di colpa. All’unico scopo di far sognare noi uomini resi schiavi dalla normalità. Noi che temiamo gli anatemi del vivere sociale e ancor più la solitudine che incombe, come un nero mantello, su chiunque sia abbastanza fiero o pazzo da ribellarsi alla gabbia del quieto vivere. Una gabbia che ogni giorno, alla stregua di vittime-carcerieri, contribuiamo a creare intorno a noi.
Fonte: Le Lettura 18/06/2017
20/06/2017